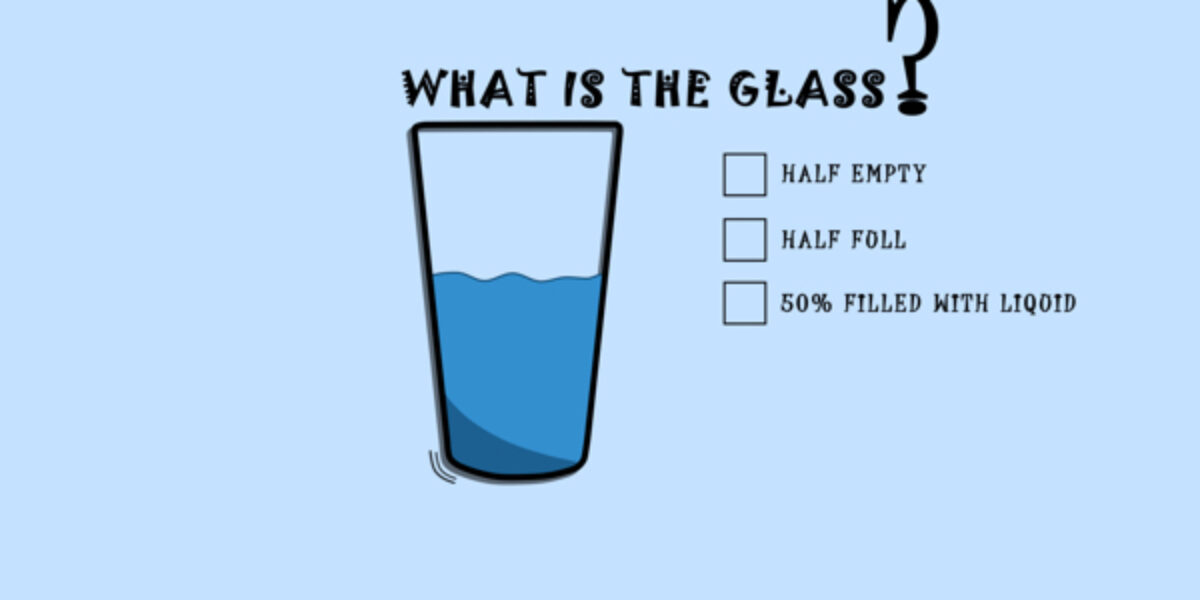Per questo ultimo articolo prima delle vacanze estive vi consiglio di cercare (e trovare!) più felicità. Ho appena letto il libro di Tal Ben Sharar “The pursuit of perfect”[1], che mostra come il nostro desiderio di perfezione sia un motore che ci spinge a migliorarci, ma costituisce anche una fonte di stress e di emozioni negative.
Tal Ben Shahar distingue il profilo del Perfezionista da quello che definisce come “Ottimalista”, secondo la seguente tabella:
|
Perfezionista |
Ottimalista |
|
Teme il fallimento e lo respinge poiché lo ritiene inaccettabile in quanto non corrisponde al mondo ideale che immagina per lui e le situazioni che vive. È quindi molto critico con sé stesso e gli altri quando si producono gli inevitabili errori della vita. E’ sempre sulla difensiva. |
Vede il fallimento come una fonte di apprendimento. Cerca di evitarlo, ma quando si verifica un errore, lo trasforma in qualcosa di positivo. Il fallimento fa parte della vita. Accettata di parlarne per tirarne la migliore lezione. |
|
Respinge le emozioni negative come inaccettabili per se stesso e per gli altri. |
Accetta le emozioni negative come parte della vita. |
|
Respinge il successo perché non è in grado di goderselo. Vede in ogni cosa il “difetto” che avrebbe potuto essere evitato e rimugina su “se avessi fatto questo e quest’altro …” |
Considera che il successo fa parte della vita, come ne fanno parte gli errori. |
|
Rifiuta la realtà perché vive sempre in un mondo ideale (e dunque irraggiungibile). |
Accetta la realtà poiché vive nel mondo reale con le sue imperfezioni, i rischi e pericoli e i suoi periodi positivi e negativi. |
|
Per lui l’obiettivo è più importante del viaggio. Tutte le sue azioni e le sue energie servono a raggiungere l’obiettivo finale a tutti i costi. Gli incidenti di viaggio sono visti come ostacoli piuttosto che come parte di ogni viaggio. |
Il viaggio è importante quanto l’obiettivo e accetta le deviazioni dalla meta come fonti di apprendimento altrettanto ricche rispetto al raggiungimento dell’obiettivo. |
Tal Ben-Shahar ha chiamato questo profilo “Ottimalista” per distinguerlo dall’ottimista. L’ottimista vede la vita un po’ ingenuamente “in rosa”, mentre l’Ottimalista sa affrontare la realtà che sia positiva o negativa.
Ovviamente nessuno è al 100% Ottimalista o Perfezionista, abbiamo tutti una parte dell’uno e dell’altro. La percentuale di uno o l’altro cambia anche a seconda della fase di vita. Spesso l’esperienza e le inevitabili battute d’arresto nella vita ci danno un po’ della saggezza che ci fa accettare la vita così com’è.
A questo punto è logico porsi la domanda seguente: poiché è ovvio che l’Ottimalista vive una vita molto più felice del Perfezionista, perché ci sono tanti Perfezionisti sul posto di lavoro? Vedo intorno a me manager che non accettano gli errori dei loro dipendenti, costringendoli a nasconderli e, di conseguenza, si ripetono all’infinito.
Il problema è questo: in ambienti con tendenza perfezionista, è più difficile imparare qualcosa dagli errori perché la gente non ne parla con il risultato che l’errore si ripete. Se non si accettano gli errori come parte della vita, è evidente che è difficile condividerli con gli altri.
Gli errori medici sono la terza causa di mortalità negli ospedali degli Stati Uniti. Alcune istituzioni sanitarie hanno indetto ricerche[2] per capire l’origine del fenomeno e cercare di ridurne gli effetti. La ragione principale di questi errori è la paura delle azioni legali dei pazienti contro i medici e gli ospedali. Pertanto, infermieri e medici considerano gli errori come un tabù, di cui non si deve parlare né tra il personale medico né con i pazienti.
Queste ricerche hanno dimostrato che, quando l’errore è ammesso come parte della vita dell’ospedale, le infermiere e i medici ne parlano tra di loro per trovare soluzioni che riducono la mortalità causata da errori ripetuti. Inoltre, la condivisione delle cause degli errori con le famiglie dei pazienti ha anche ridotto il tasso di denuncia e la quantità di danni richiesti.
La condivisione degli errori è la chiave principale per trovare la soluzione ed anche della sua trasmissione in modo che l’errore non venga più ripetuto all’interno di un’organizzazione.
Fin dalla tenera età i bambini imparano che devono avere successo nella vita, che è necessario avere buoni, e anche eccellenti, voti per entrare in questa o quella prestigiosa scuola che a sua volta aprirà le porte delle migliori università, per poi avere la possibilità di trovare il miglior lavoro … In tutto ciò, i bambini, gli adolescenti, gli studenti e i giovani che entrano nel mondo del lavoro come possono trovare il tempo di imparare dai loro errori? Se gli errori non sono ammessi fin dalla prima infanzia, come possono i giovani adulti imparare a condividerli a risolverli con gli altri?
Essere Ottimalista non vuol dire non essere ambizioso e non non volere migliorare le cose. Gli Ottimalisti vivono meglio e imparano più velocemente e con meno sofferenza dal momento che l’errore fa parte della loro vita, come della vita in generale. L’Ottimalista sa anche che l’errore è la sua principale fonte di apprendimento. Ricordiamo quante volte un bambino cade prima di imparare a camminare! E pensiamo alla scoperta della penicillina che ha salvato milioni di vite ed è nata da un errore. Infatti, nel 1928, il Doctor Fleming al suo ritorno dalle vacanze, ritrovo’ nelle sue scatole di cultura di stafilococchi una sorta di muffa che era cresciuta durante la sua assenza e che in seguito divenne la penicillina miracolosa, usata per trattare le infezioni.
E ‘stato anche dimostrato che gli Ottimalisti vivono molto meglio dei Perfezionisti perché sanno assaporare il successo e condividerlo con coloro che li circondano.
Dopo aver letto questo articolo, avete ancora dei dubbi? Vi invito a approfittare dell’estate per pensare alla vostra felicità e aumentare la percentuale di Ottimalista che è in voi!
[1] Questo libro non è tradotto in italiano, ma potete leggere altri libri di Tal Ben Shahar come « Più felice » e « La felicità in tasca »
[2] Cf per esempio le ricerche citate in questo articolo del New York Times « When doctors admit their mistake » 19 agosto 2010, scritto da Pauline W. Chen. ; l’articolo « Error reporting and disclosure » di Zane Robinson Wolf e Rhonda G ; Hughes http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2652/